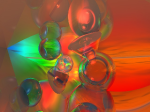Abbreviazioni:
AN: Aṅguttara Nikāya
SN: Saṃyutta Nikāya
MN: Majjhima Nikāya
Ud: Udāna
Iti: Itivuttaka
Sn: Sutta Nipāta
Vism: Visuddhimagga
PTS: Pali Text Society
Introduzione
Fin da quello che la tradizione ricorda come il suo primo discorso pubblico, ovvero il celeberrimo Dhammacakkappavattana-sutta (“Discorso della messa in moto della ruota del Dhamma”, SN 56.11), il Buddha ha proposto un sistema non già teoretico ma eminentemente pratico, indicandone la meta finale in termini di visione (cakkhu), conoscenza (ñāṇa), quiete (upasama), super-conoscenza (abhiññā), perfetta comprensione (sambodha) ed estinzione (nibbāna) (PTS 5.420). Il presente contributo intende fornire delle riflessioni di carattere filosofico a proposito di quest’ultimo “concetto”, dapprima calandolo nella prospettiva fenomenologica, ove il buddhismo – nell’autorevole opinione di vari studiosi[2] – sembra trovarsi a suo agio più che in altre, successivamente mostrando di essa i limiti ermeneutici e restituendo del nibbāna la sua impossibilità a essere compreso in termini filosofici univoci.
Continua a leggere