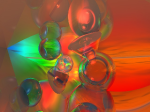Abbreviazioni:
AN: Aṅguttara Nikāya;
Dhp: Dhammapada;
Iti: Itivuttaka;
MN: Majjhima Nikāya;
PTS: Pali Text Society;
SN: Saṃyutta Nikāya;
Sn: Sutta Nipāta;
Ud: Udāna;
Vism: Visuddhimagga.
Introduzione
Al principio del Sn si trova l’Uraga-sutta, il sutta del serpente, dove viene ripetuta un’affermazione forte, ovvero “tutto questo è irreale” (sabbaṃ vitatham idaṃ, PTS 2), secondo le traduzioni di Vincenzo Talamo (2019: 206) e Bhikkhu Bodhi (“all this is unreal”; 2017: 158).
L’interpretazione commentariale
Ora, come interpretare questa sentenza? Prima facie, si potrebbe pensare che essa autorizzi un’interpretazione schiettamente nichilista, benché asserire che qualcosa sia irreale non implica necessariamente che non esista; in ogni caso, siffatta lettura è smentita inequivocabilmente dal commentario al Sn, la Paramatthajotikā (II) attribuita a Buddhaghosa (V d.C.). Questo testo fornisce una glossa puntuale al testo radice: sabbaṃ viene dunque chiosato con anavasesaṃ, “senza resto”, “senza eccezione”, e sakalam anūnaṃ, “intero, non mancante di nulla”. Tuttavia, precisa il commentario, qui con sabba s’intendono soltanto le cose condizionate (saṅkhatam eva) atte alla visione profonda (vipassanupagaṃ), del tipo di mondani aggregati, basi sensoriali ed elementi (lokiyakhandhāyatanadhātuppabhedaṃ) (PTS 1.21).
Quindi si passa ad analizzare il senso del cruciale termine “irreale” (vitatha), glossato come vigatatathabhāvaṃ, ovvero: “privo di un’effettiva natura”. In che senso? Nel senso, prosegue il commentario, di una natura concepita dalle persone stolte (bālajanehi), per il potere delle contaminazioni (kilesavasena), come permanente (nicca), piacevole (sukha), attraente (subha) o come sé sostanziale (attā) (PTS 1.21). Cosa sono queste qualificazioni? Sono i quattro vipallāsa, di cui parleremo tra breve. Le realtà condizionate sono “irreali” in questo senso: non in senso assoluto, ma nel senso relativo di mancare di una natura concepita nel modo anzidetto. Non è che il mondo non esista sic et simpliciter, ma non esiste con quelle caratteristiche: con le parole di Nyanaponika Thera (2009: 58), l’irrealtà sta in ciò che attribuiamo al mondo, non nel mondo stesso.
Per conoscere il mondo come “irreale” nel senso or ora esposto, occorre compiere un lavoro di purificazione mentale: non a caso, i versi dal decimo al tredicesimo dell’Uraga-sutta mettono in relazione l’insight della natura del mondo con l’assenza di avidità (vītalobha), concupiscenza (vītarāga), odio (vītadosa) e illusione (vītamoha). Una mente così, immacolata, è capace di pervenire alla corretta conoscenza del mondo nella sua vera natura, mentre l’uomo comune, con una mente ineducata, rimane soggetto alle sue stesse illusioni cognitive, con tutto il portato di sofferenza che ciò comporta. Nel Sammāparibbājanīya-sutta del Sn (PTS 64) compare un aggettivo interessante: vivaṭṭacchada, che Talamo (2019: 248) traduce come “che ha sollevato il velo” e il commentario spiega come vivaṭarāgadosamohachadano (PTS 1.364), ovvero il cui velo di rāga, dosa e moha è stato rimosso. Immediatamente prima, compare il termine saṃsuddhajina, che significa “il conquistatore purificato”, cioè, come precisa il commentario (PTS 1.365), colui che ha sconfitto le contaminazioni (vijitakilesa) che oscurano la mente e ne riducono il potenziale di visione profonda. È dunque chiaro come soltanto una mente purificata sia in grado di superare il velo dell’illusione e ottenere così una conoscenza e visione conformi alla vera natura del mondo. Il vero brāhmaṇa non è tale per nascita, ma per il fatto di aver sviluppato buone qualità mentali: tra queste, il Vāseṭṭha-sutta del Sn menziona il superamento proprio dell’illusione (moham accagā) (PTS 120).
Le quattro distorsioni (vipallāsa)
Il Vipallāsa-sutta (AN 4.49) è un testo canonico che individua quattro distorsioni della percezione (saññāvipallāsa), della mente (cittavipallāsa) e della visione (diṭṭhivipallāsa) foriere di dukkha: considerare l’impermanente come permanente, la sofferenza come felicità, il non-sé come sé, il repellente come attraente, cui fanno da pendant, all’inverso, quattro non-distorsioni della percezione (nasaññāvipallāsa), della mente (nacittavipallāsa) e della visione (nadiṭṭhivipallāsa), che costituiscono la giusta prospettiva sulle cose. Gli esseri non educati al Dhamma sono afflitti da errata visione (micchādiṭṭhihata), squilibrio mentale (khittacitta) e percezione distorta (visaññī): sotto il giogo (yogayutta) di Māra, vagano nel saṃsāra (sattā gacchanti saṃsāraṃ), di nascita in morte (jātimaraṇagāmī) (PTS 2.51). Ma dal momento in cui nel mondo sorgono i Buddha, luciferi (pabhaṅkara[2]; ancora in termini di luminosità è detto il Buddha nel Pajjota-sutta [SN 1.26, PTS 1.14], dove si afferma che egli sia l’insorpassabile fulgidità: ābhā anuttara), grazie al loro insegnamento del Dhamma, che porta all’acquietamento della sofferenza (dukkhūpasamagāmin), coloro che sono dotati di comprensione profonda (te sappaññā), assumendo la retta visione (sammādiṭṭhisamādāna), trascendono ogni sofferenza (sabbaṃ dukkhaṃ upaccaguṃ) (PTS 2.52).
Anche il XXII capitolo del Visuddhimagga[3] menziona i “capovolgimenti”, i vipallāsa (sanscrito: viparyāsa), al paragrafo 47, indicandoli come dhamma che devono essere abbandonati e definendoli poco oltre (Vism XXII, 53) come “i tre fraintendimenti della percezione, della mente e della visione, che si manifestano vedendo la permanenza, la felicità, il sé e la bellezza in oggetti impermanenti, dolorosi, privi di sé e brutti”. Nello specifico (Vism XXII, 68),
la prima conoscenza [quella legata al sentiero dell’ingresso nella corrente, sotāpattimagga] elimina i fraintendimenti della percezione, della mente e della visione, [che si manifestano vedendo] la permanenza in ciò che è impermanente e il sé in ciò che è privo di sé, e il fraintendimento della visione [che si manifesta vedendo] la felicità in ciò che è doloroso e la bellezza in ciò che è brutto. La terza conoscenza [quella legata al sentiero di chi non ritorna, anāgāmimagga] elimina i fraintendimenti della percezione e della mente, [che si manifestano vedendo] la bellezza in ciò che è brutto. La quarta conoscenza [quella legata al sentiero dell’arahantship, arahattamagga] elimina i fraintendimenti della percezione e della mente, [che si manifestano vedendo] la felicità in ciò che è doloroso.
En passant, notiamo che non viene menzionata la seconda conoscenza, ovvero quella legata al sentiero di chi ritorna una sola volta (sakadāgāmimagga): nel brano citato, si passa direttamente dalla prima alla terza conoscenza. In questo contesto, peraltro, non è il solo caso in cui ciò avvenga.
Ad ogni modo, qual è il metodo per contrastare i vipallāsa? L’impiego sistematico della consapevolezza, rivolta a questo o quell’ambito di contemplazione in particolare a seconda del vipallāsa da contrastare. Nel Suttapiṭaka non si trova esplicitamente l’indicazione dei satipaṭṭhāna come antidoti ai vipallāsa, mentre ciò avviene nel Nettippakaraṇa (non in tutto il mondo theravāda ritenuto canonico) e nel Visuddhimagga (Anālayo 2018: 27-28), nonché, nella tradizione Sarvāstivāda, nell’*Abhidharmahṛdayaśāstra (Kosaka 2021: 9) e nell’*Abhidharmamahāvibhāṣā (Kosaka 2021: 31): i quattro smṛtyupasthāna sono gli antidoti (pratipakṣa) ai caturviparyāsa, i “quattro fraintendimenti”; in particolare, il kāyasmṛtyupasthāna è l’antidoto al śuciviparyāsa (l’inversione per cui ciò che è impuro è considerato come puro), il vedanāsmṛtyupasthāna al sukhaviparyāsa (l’inversione per cui ciò che è sofferenza è considerato come felicità), il cittasmṛtyupasthāna al nityaviparyāsa (l’inversione per cui ciò che è impermanente è considerato come permanente) e il dharmasmṛtyupasthāna all’ātmaviparyāsa (l’inversione per cui ciò che è non-sé è considerato come sé) (Kosaka 2021: 31; Dhammajoti 2009: 466). Analogamente, secondo i due testi pāli prima menzionati – scrive Anālayo (2018: 28) -,
la contemplazione del corpo ha il potenziale di rivelare, in particolare, l’assenza di bellezza fisica; l’osservazione della vera natura delle sensazioni può fare da contrappeso all’incessante ricerca di piaceri effimeri; la consapevolezza del continuo succedersi degli stati mentali può svelare il carattere impermanente dell’esperienza soggettiva; e la contemplazione dei dhamma può rivelare come l’idea di un sé sostanziale e permanente non sia altro che un’illusione.
La Yogācārabhūmi, dal canto suo, descrive l’eliminazione dei viparyāsa non attraverso gli smṛtyupasthāna, ma attraverso i “sigilli del dharma” (dharmamudrā): osservare che tutte le cose condizionate sono impermanenti è l’antidoto al nityaviparyāsa, osservare che sono di natura insoddisfacente è l’antidoto al sukhaviparyāsa, osservare, finalmente, che mancano di un sé solido, separato e indipendente è l’antidoto all’ātmaviparyāsa (Kosaka 2021: 33-34).
I quattro viparyāsa della tradizione buddhista si ritrovano nello Yogasūtra (II.5), sussunti sotto la categoria di “ignoranza” (avidyā). Menzionati inoltre nell’Abhidharmakośabhāṣya (V.9) di Vasubandhu (catvāro viparyāsāḥ, anitye nityam iti, duḥkhe sukham iti, aśucau śucīti, anātmany ātmeti) (Gokhale 2020: 110), a proposito dei viparyāsa e del loro rapporto con l’avidyā nella Yogācārabhūmi (166) si trova scritto che l’ignoranza è la radice dell’inversione (viparyāsamūlam avidyā) (Gokhale 2020: 72, 110). Come osservato da Gokhale (2020: 72), Patañjali da par sua sembra compiere un passo ulteriore, stabilendo un rapporto di reciproca identificazione tra avidyā e viparyāsa.
A proposito del fraintendimento dell’impermanente come permanente, è interessante notare come persino le divinità cadano in siffatto errore. Nel Bakabrahma-sutta (SN 6.4) si dice, infatti, che nel dio Baka sorse il seguente punto di vista (diṭṭhigata) dannoso (pāpaka): questo, glossato da Talamo (1998: 127) come “il mondo di Brahmā”, è permanente (idaṃ niccaṃ), questo è duraturo (idaṃ dhuvaṃ), questo è eterno (idaṃ sassataṃ), questo è di natura indefettibile (idaṃ acavanadhammaṃ); questo effettivamente (idañhi) non nasce (na jāyati), non invecchia (na jīyati), non muore (na mīyati), non viene meno (na cavati). Il Buddha, in risposta, afferma che il dio è immerso nell’ignoranza (avijjāgata), poiché concepisce oppostamente le cose, anziché considerarle nella giusta prospettiva (PTS 1.142). Nel Sīha-sutta (SN 22.78) si parla ancora delle divinità e del loro fraintendimento. Qui si dice che il Buddha insegna: così è la forma materiale (iti rūpaṃ), così la sua origine (iti rūpassa samudayo), così il suo disparire (iti rūpassa atthaṅgamo), e allo stesso modo coi rimanenti aggregati. Quando le divinità (deva) ascoltano il Dhamma annunciato dal Tathāgata (ricorrente epiteto del Buddha, peraltro di incerta etimologia), pur godendo di una lunga vita (dīghāyuka), sono colte in gran parte da paura (bhaya), senso di urgenza (saṃvega) e terrore (santāsa), poiché scoprono di essere impermanenti (anicca), non-durature (addhuva) e non-eterne (asassata), sebbene credessero il contrario. Esse, all’udire l’insegnamento del Buddha, provano paura (bhīta) e sperimentano terrore (santāsam āpādi) al modo degli animali che odono un leone (sīha) (PTS 3.84-85).
Divellere la visione del sé (attānudiṭṭhi)
Per sradicare la visione del sé, il mondo è da contemplarsi come vuoto: tale l’invito, l’istruzione di pratica del Buddha a Mogharāja verso la fine del Sn (PTS 216): suññato lokaṃ avekkhassu, “guarda/considera il mondo come vuoto”, sadā sato, in modo sempre consapevole, nel senso spiegato dal commentario di sviluppare la consapevolezza attraverso i quattro satipaṭṭhāna (Bodhi 2017: 1314), poiché, divellendo la visione del sé (attānudiṭṭhiṃ ūhacca), diviene possibile superare la morte (evaṃ maccutaro siyā). Infatti, il re della morte (maccurāja) non vede chi così guarda/considera il mondo (evaṃ lokaṃ avekkhantaṃ).
Il Niddesa (II) precisa che il mondo è vuoto per due ragioni: la prima è legata alla considerazione che la sua occorrenza non è sotto il proprio potere (avasiya), la seconda alla contemplazione (samanupassanā) come consistente di cose condizionate e vuote (tucchasaṅkhāra). Lo stesso testo puntualizza subito dopo che lo sradicamento della visione del sé significa la rimozione della “visione della personalità” (sakkāyadiṭṭhi)[4] (Bodhi 2017: 1310). In che maniera considerare il verificarsi del mondo come al di là del proprio controllo? Considerando che la padronanza dei khandha non è possibile; diversamente, sarebbe possibile ottenere a comando che ciascuno sia in un modo o non sia in un altro (Bodhi 2017: 1310-1311). Ma, come dice il Visuddhimagga (XXI, 8), la pentade degli aggregati è non-sé proprio perché è “incontrollabile” (avasavattana), ovvero non è sotto il proprio controllo, non soggiace alla propria volontà: la caratteristica del non-sé è esattamente “l’aspetto dell’incontrollabilità”, secondo la traduzione italiana di Antonella Serena Comba.
In che maniera, poi, considerare il mondo contemplandolo come costituito da cose vuote e condizionate? Considerando che nei khandha non si trova alcun sāra, ovvero nucleo, essenza, sostanza. Considerando, cioè, che ciascun aggregato è privo di essenza (assāra), insostanziale (nissāra), privo di nucleo (sārāpagata). In che senso? Nel senso di qualsiasi nucleo di permanenza (niccasārasāra), nucleo di felicità (sukhasārasāra), nucleo del sé (attasārasāra) o comunque qualsiasi cosa di permanente (nicca), stabile (dhuva), sempiterna (sassata) e di natura immutabile (avipariṇāmadhamma) (Bodhi 2017: 1311-1312).
Con grande dettaglio analitico, il testo esegetico prosegue indicando come contemplazione della vacuità del mondo gruppi di sei modi l’uno: l’occhio (cakkhu) è vuoto di sé o di qualsiasi cosa appartenga al sé (cakkhu suññaṃ attena vā attaniyena) o comunque di permanente, stabile, sempiterna e di natura immutabile; allo stesso modo coi restanti organi di senso, con la mente (mano) come sesto e ultimo. In identico modo è per gli ambiti oggettuali degli organi di senso, dalle forme materiali (rūpa) ai fenomeni mentali (dhamma); per le coscienze sensoriali, da quella visiva (cakkhuviññāṇa) a quella mentale (manoviññāṇa); per i contatti, da quello visivo (cakkhusamphassa) a quello mentale (manosamphassa); per le sensazioni, da quella nata dal contatto visivo (cakkhusamphassajāvedanā) a quella nata dal contatto mentale (manosamphassajāvedanā); per le percezioni, da quella visiva (rūpasaññā) a quella dei fenomeni mentali (dhammasaññā); per le volizioni, da quella relativa alle forme (rūpasañcetanā) a quella relativa ai fenomeni mentali (dhammasañcetanā); per i diversi tipi di brama, da quella per la forma (rūpataṇhā) a quella per i fenomeni mentali (dhammataṇhā); per i diversi tipi di pensiero, da quello concernente la forma (rūpavitakka) a quello concernente i fenomeni mentali (dhammavitakka); infine, per l’investigazione, da quella riguardante le forme (rūpavicāra) a quella dei fenomeni mentali (dhammavicāra) (Bodhi 2017: 1312).
Il mondo può essere considerato come vuoto anche in dieci modi: in questo caso, la forma (rūpa) è da vedersi come vuota (ritta), con niente dentro (tuccha), insostanziale (suñña), impersonale (anattā), priva di essenza (asāraka), killer (vadhaka), sterminio (vibhava), radice della miseria (aghamūla), con influssi nocivi (sāsava) e, infine, come condizionata (saṅkhata). Lo stesso si ripete per sensazione (vedanā), percezione (saññā), saṅkhāra, coscienza (viññāṇa), morire (cuti), ri-sorgere (upapatti), concezione (paṭisandhi), esistenza/divenire (bhava) e, finalmente, circolo della rinascita (saṃsāravaṭṭa) (Bodhi 2017: 1312). Di più: è possibile contemplare il mondo in dodici modi, considerando ogni aggregato come non un essere (na satto), non un’anima (na jīvo), non una persona (na naro), non un essere umano (na māṇavo), non una donna (na itthī), non un uomo (na puriso), non un sé (na attā), non appartenente a un sé (na attaniyaṃ), non un “io” (na ahaṃ), non “mio” (na mama), non “qualcuno” (na koci) e, da ultimo, non appartenente ad alcuno (na kassaci) (Bodhi 2017: 1312).
Il Niddesa (II) prosegue chiarendo il significato di attānudiṭṭhiṃ ūhacca attraverso una serie di sinonimi, ovvero: dopo aver sradicato (ūhacca) la visione del sé, estratta (samūhacca), tirata fuori (uddharitvā), completamente tirata fuori (samuddharitvā), tirata via (uppāṭayitvā), completamente tirata via (samuppāṭayitvā), abbandonata (pajahitvā), dissipata (vinodetvā), annientata (anabhāvaṃ). Cosa diviene possibile fare allorché siffatta rimozione totale sia attuata? Così si oltrepassa la morte: evaṃ maccutaro siyā, espressione commentata in termini di attraversamento (il verbo adoprato è tareyyāsi, ottativo di tarati, “attraversare”) della morte (maccu), della vecchiaia (jarā), e di maraṇa, termine che pure ha il significato di “morte” (Bodhi 2017: 1314-1315). Per distinguere maraṇa da maccu, Bhikkhu Bodhi (2017: 1315) rende quest’ultimo come “mortalità”.
Abbandonando la visione del sé, tutto ciò è eliminato, superato, trasceso: i verbi pāli sinonimici adoprati sono, oltre al già menzionato tareyyāsi, uttareyyāsi, patareyyāsi, samatikkameyyāsi e vītivatteyyāsi, ovvero, secondo la traduzione di Bhikkhu Bodhi (2017: 1315), rispettivamente cross over, cross out of them, cross beyond them, overcome them, transcend them. Poiché muore solo chi è nato, superare la morte significa superare anche la nascita o la rinascita, tanto che per indicare questo trascendimento viene usato il composto jātimaraṇa, “nascita e morte”: i bhikkhu che superano avidità e avversione (rāgadosa) oltrepassano nascita e morte, dice il Buddha nell’Adantaagutta-sutta (SN 35.94, PTS 4.71). Come sostiene la bhikkhunī Cālā nel sutta che da lei prende il nome (SN 5.6), l’insegnamento del Dhamma da parte del Buddha volge verso il trascendimento della nascita (jātiyā samatikkamaṃ) e così verso l’abbandono di ogni sofferenza (sabbadukkhappahāna) (PTS 1.132): chi lo studi e pratichi, fino a portarlo a compimento con l’arahantship (arahatta), è liberato da ogni sofferenza: sabbadukkhā pamuccati, si legge nel Kasibhāradvāja-sutta del Sn (PTS 13), glossato dal commentario con tutta la sofferenza dell’esistenza ciclica (vaṭṭadukkha), la sofferenza della sofferenza (dukkhadukkha), la sofferenza dovuta alle cose condizionate (saṅkhāradukkha) e la sofferenza dovuta al cambiamento (vipariṇāmadukkha) (Bodhi 2017: 517).
Le ultime tre specie di sofferenza corrispondono a quelle menzionate nel Dukkhatā-sutta (SN 45.165, PTS 5.56) e nel Dukkhapañhā-sutta (SN 38.14, PTS 4.258) in forma astratta: la dukkhadukkhatā, vale a dire la sofferenza nelle sue manifestazioni macroscopiche ed evidenti, sia fisiche che mentali; la saṅkhāradukkhatā, vale a dire la sofferenza dovuta al carattere condizionato e perciò transitorio dell’esistenza in ogni suo momento e manifestazione; infine, la vipariṇāmadukkhatā, vale a dire la sofferenza dovuta all’inevitabile cambiamento. Il Dukkhatā-sutta si conclude affermando che il nobile ottuplice sentiero dovrebbe essere coltivato per la conoscenza diretta (abhiññā) di questi tre tipi di sofferenza, per la loro piena comprensione (pariññā), per la loro estinzione (parikkhaya) e per il loro abbandono (pahāna). Le stesse parole del Buddha sono capaci di dissipare ogni sofferenza, come si dice nell’Āmagandha-sutta del Sn (PTS 44): esse sono ben dette (subhāsita), incontaminate (nirāmagandha) – nel senso spiegato dal commentario di essere nikkilesayoga, prive di contaminazione (Bodhi 2017: 726) – e, appunto, sabbadukkhappanūdana, dissipanti tutta la sofferenza, ovvero, come glossa il commentario, sabbavaṭṭadukkhappanūdana, vale a dire dissipanti tutta la sofferenza dell’esistenza ciclica.
Anche nello stesso Sn è presente il composto jātimaraṇa, in particolare nel Dhaniya-sutta (PTS 5), dove il pastore da cui il discorso prende il nome dice di voler condurre vita religiosa (brahmacariya) presso il Sugata – epiteto del Buddha il cui significato letterale è “ben andato” – allo scopo di andare oltre proprio “nascita e morte” e in tal modo por fine alla sofferenza (dukkhass’ antakara). Il commentario spiega che al di là di nascita e morte significa il nibbāna (Bodhi 2017: 396), detto nella Kappamāṇavapucchā del Sn isola (dīpa) impareggiabile (anāpara) e, giustappunto, distruzione completa di nascita e morte (jarāmaccuparikkhaya) (PTS 211). Come dice il Bhagavant, avendo egli reciso i legami (bandhana), ed essendo dunque assoluto, divincolatosi nell’accezione arcaica del termine, svincolato, libero, non entrerà più in un grembo (gabbhaseyyā) (PTS 4): questo sostantivo femminile pāli alla lettera significa “letto del grembo” e, come spiega il commentario, si riferisce con gabbha, “grembo”, alla modalità di generazione che comporta la nascita dal grembo, e con seyyā, “letto”, alle altre (Bodhi 2017: 394). Colui che – tra le altre cose – abbia conseguito l’estinzione della nascita o rinascita (jātikkhaya), quello è detto brāhmaṇa dal Buddha nel Vāseṭṭha-sutta del Sn (PTS 121).
Un altro composto utilizzato è jātijarā, “nascita e decrepitezza”, poiché, di nuovo, solo chi è nato invecchia; ma chi riesca a tagliare questa catena (saṃyojana) e sia satimant, “consapevole”, nipaka, “intelligente”, jhāyī, “meditativo”, nel senso particolare di coltivare quegli assorbimenti contemplativi di crescente profondità e sottigliezza che sono i jhāna, ātāpī, “ardente”, ottāpī, “scrupoloso”, e appamatta, “diligente”, consegue in questa stessa vita, proprio qui (idh’ eva), il supremo e perfetto risveglio (sambodhim anuttaraṃ): così nei versi dell’Ātāpī-sutta (Iti 34, PTS 27).
[1] Ringrazio cordialmente Chiara Neri e Giuliano Giustarini per la lettura del presente contributo e per i suggerimenti datimi per il suo miglioramento.
[2] Lo stesso termine compare nel Punabbasu-sutta (SN 10.7, PTS 1.210), dove il personaggio omonimo lo riferisce al Buddha, detto, appunto, “portatore di luce”, in particolare per dèi ed esseri umani (devamanussā) perduti (sammūḷha), nonché colui che è alla sua ultima esistenza (antimasārīra) e che cakkhumant, dotato di vista, di vista informata dalla saggezza emancipatrice, insegna il Dhamma.
[3] Tutte le citazioni italiane dal Visuddhimagga sono opera di Antonella Serena Comba (2010).
[4] Nel Mahāpuṇṇama-sutta (M 109, PTS 3.16-3.17) il Buddha afferma che la sakkāyadiṭṭhi, propria della persona ordinaria (puthujjana), si origini allorché si veda la forma come sé (rūpaṃ attato), il sé come possessore di forma (rūpavantaṃ vā attānaṃ), la forma nel sé (attani vā rūpaṃ) o il sé nella forma (rūpasmiṃ vā attānaṃ), e allo stesso modo coi successivi aggregati (khandha). Questo set di possibilità esaurisce i modi di pensare il rapporto tra il sé e un aggregato. Benché il termine sakkāya faccia riferimento al solo “corpo” (kāya), come ha osservato Bhikkhu Bodhi (2017: 1369) “what is meant is not solely the physical body but the entire conglomeration of material and mental factors that constitute the empirical person”.