
Ancora sulla vacuità
Ritorniamo ora al tema della contemplazione della vacuità: nella tradizione theravāda, il concetto di vacuità (suññatā) corrisponde a quello di non-sé (anattā), vale a dire la mancanza di un principio identitario immutabile, indipendente ed essenziale nella costituzione psicofisica umana. Nel suo Visuddhimagga (XX, 91; XXII, 117), Buddhaghosa è chiaro: la contemplazione della vacuità è la stessa cosa della contemplazione del non-sé. La nozione di vacuità è stata profondamente elaborata dal Mahāyāna, che ne elenca diverse forme (Williams 2002: 127-128), come del resto avviene anche nel Canone pāli: il Paṭisambhidāmagga (II d.C. ca., von Hinüber 1996: 60) ha un intero capitolo, intitolato Suññakathā, in cui del vuoto si fa un’analisi sistematica (caso unico nel Canone pāli)[1], com’è tipico dello spirito indiano, meticolosamente classificatorio, e in modo particolare della scolastica buddhista, di cui il Paṭisambhidāmagga fa parte, sebbene non sia stato incluso nell’Abhidhammapiṭaka. Ciò verosimilmente per il fatto di essere stato composto tardivamente, quando il canestro dell’Abhidhamma era già stato chiuso (von Hinüber 1996: 59-60), a differenza del Khuddakanikāya, più a lungo rimasto aperto e tale, dunque, da poter accogliere anche opere seriori.
Ad ogni modo, nel testo in questione il vuoto è considerato da molteplici punti di vista: ben venticinque, ciascuno discusso singolarmente, ma noi, per non debordare dai limiti entro cui deve collocarsi il presente contributo, possiamo soltanto nominarli, nella traduzione inglese di Bhikkhu Ñāṇamoli (1982: 356, PTS 2.177):
- suññasuñña, voidness as voidness;
- saṅkhārasuñña, voidness of formations;
- vipariṇāmasuñña, voidness in change;
- aggasuñña, supreme voidness;
- lakkhaṇasuñña, voidness by characteristic;
- vikkhambhanasuñña, voidness by suppression;
- tadaṅgasuñña, voidness by substitution of opposites;
- samucchedasuñña, voidness by cutting off;
- paṭippassaddhisuñña, voidness by tranquillization;
- nissaraṇasuñña, voidness as escape;
- ajjhattasuñña, internal voidness;
- bahiddhāsuñña, external voidness;
- dubhatosuñña, voidness in both ways;
- sabhāgasuñña, similar voidness;
- visabhāgasuñña, dissimilar voidness;
- esanāsuñña, voidness in search;
- pariggahasuñña, voidness in embracing;
- paṭilābhasuñña, voidness in obtainment;
- paṭivedhasuñña, voidness in penetration;
- ekattasuñña, voidness in unity;
- nānattasuñña, voidness in difference;
- khantisuñña, voidness in choice;
- adhiṭṭhānasuñña, voidness in steadiness;
- pariyogāhaṇasuñña, voidness in fathoming;
- infine, vacuità nel significato ultimo (paramatthasuñña) di tutti i tipi di vacuità (sabbasuññatāna).
Il Sn ribadisce la vacuità del mondo verso l’inizio dell’Attadaṇḍa-sutta (PTS 181), dove se ne afferma il carattere samantamasāra, completamente privo di essenza o sostanzialità, ovvero, come glossa la Paramatthajotikā, da ogni parte/ovunque (samantato) substance-less (asāra), manchevole di un’essenza permanente (niccasārādirahita) (Bodhi 2017: 1191). Il Niddesa (I) precisa ulteriormente questo passaggio, chiarendo anzitutto cosa s’intenda con “mondo” (loka): il mondo dell’inferno (nirayaloka), il mondo degli animali (tiracchānayoniloka), il mondo degli spiriti famelici (pettivisayaloka), il mondo degli esseri umani (manussaloka), il mondo degli dèi (devaloka), il mondo degli aggregati (khandhaloka), il mondo degli elementi (dhātuloka), il mondo delle basi sensoriali (āyatanaloka), questo mondo (ayaṃ loko), l’altro mondo (paro loko), il mondo di Brahma (brahmaloka), il mondo degli dèi (devaloka). Ciascuno di questi mondi – prosegue il testo esegetico – è privo di essenza (asāra), insostanziale (nissāra), privo di nucleo (sārāpagata), senza nucleo di permanenza (niccasārasāra), nucleo di felicità (sukhasārasāra), nucleo del sé (attasārasāra), mancante di qualsiasi cosa di permanente, stabile, sempiterna e di natura immutabile. Quindi il mondo viene paragonato all’insostanzialità – espressa dagli stessi termini asāra, nissāra e sārāpagata – di varie piante, a partire dalla canna (naḷa), e poi di un grumo di schiuma (pheṇapiṇḍa), di una bolla d’acqua (udakapubbuḷa), di un miraggio (marīci), di un tronco di banano (kadalikkhandha) e del trucco di un prestigiatore (māyā) (Bodhi 2017: 1191). Gli ultimi cinque termini, con l’aggiunta finale dell’aggettivo upama, “simile”, “come”, figurano anche nei versi del Buddha nel Pheṇapiṇḍūpama-sutta (SN 22.95, PTS 3.142), in riferimento rispettivamente ai cinque aggregati. Successivamente, Buddhaghosa riprenderà alcuni di questi termini nel suo Visuddhimagga (XX, 104), quando, parlando dei saṅkhāra, ovvero di tutto ciò che è condizionato, quale si mostra in vipassanā all’occhio rischiarato dalla sapienza (paññā), dice:
è evidente che esse [le “formazioni”] non hanno un’essenza, ma ne sono sprovviste, come un gioco di prestigio [māyā], come un miraggio [marīci], come un sogno [supinanta], come un cerchio tracciato con un tizzone ardente [alātacakka[2]], come una città di gandhabba [gandhabbanagara], come la schiuma [pheṇa], come il tronco di un banano [kadali] ecc.[3]
Quello di vacuità/non-sé è un elemento dottrinale così caratteristico del buddhismo che questo in ambito brahmanico-vedantico divenne noto come nairātmyavāda (Pelissero 2014: 144). Effettivamente, la tradizione buddhista sanscrita distingue due specie di insostanzialità: il pudgalanairātmya, ovvero l’insostanzialità della persona, e il dharmanairātmya, ovvero l’insostanzialità dei dharma. Nella volgarizzazione della storia del buddhismo indiano, il dharmanairātmya è talvolta presentato come un’innovazione del Mahāyāna (Williams 1990: 59), ma invero si tratta di un concetto già noto al buddhismo antico (Gombrich 2012: 32; Williams 2002: 129; Williams 1990: 59-61; Ruegg 1981: 7), in particolare al Canone pāli, dove in più di un testo[4] tutti i dhamma – sia, dunque, quelli condizionati (saṅkhata) che quell’unico incondizionato (asaṅkhata) che è il nibbāna – sono detti non-sé (sabbe dhammā anattā).
La consapevolezza della vacuità è il risultato dell’osservazione assidua e profonda dei dati fisici e mentali che si manifestano momento dopo momento e, potremmo dire fenomenologicamente, nei limiti del loro manifestarsi: osservandoli, si viene a conoscere per esperienza diretta che niente possiede quel carattere di identica permanenza nel tempo che ci si attenderebbe da qualche cosa che fosse sostanziale. Poiché, dunque, nulla permane identicamente, nulla può fornire una soddisfazione duratura e nulla costituisce una sostanza dotata di inscalfibile identità e caratteri essenziali: tali le tre caratteristiche universali (tilakkhaṇa: impermanenza, carattere insoddisfacente, non-sé) di ciò che è condizionato/composto (saṅkhata), ovvero, secondo il Theravāda, tutto ad eccezione del nibbāna, detto nel Ratana-sutta del Sn (PTS 40) “sommo (parama) bene (hita)”, secondo la traduzione di Talamo (2019: 231).
Nel Sammāparibbājanīya-sutta sempre del Sn sono presenti degli epiteti dell’arahant (PTS 62), qualificato per mezzo del termine tiṇṇa, “che è andato oltre”, e dell’aggettivo pāraṅgata, ovvero “che è andato all’altra sponda”, “andato al di là”, che ha superato il torrente (oghatiṇṇa), con chiaro riferimento al raggiungimento del nibbāna, tant’è vero che subito dopo compare il termine parinibbuta. Nello stesso luogo testuale (PTS 64), compare poi il termine pāragū, che di nuovo designa chi è andato oltre, conseguendo il nibbāna con residuo (saupādisesa), come precisa il commentario (Bodhi 2017: 842). Ordunque, volgiamoci verso il tema del nibbāna nel tentativo di capire se sia questo a poter essere inteso nichilisticamente.
Forse che, se non il mondo, è il nibbāna ad esser nulla?
Quando il buddhismo cominciò ad essere conosciuto in Occidente, a partire dai resoconti dei missionari del XVIII secolo, si formò e, nel secolo successivo, si affermò quel fraintendimento che vedeva nel fine soteriologico di questa religione, il nibbāna (sanscrito: nirvāṇa), l’annientamento della persona. Si tratta di una grave incomprensione, dipendente da una lettura parziale e superficiale dei testi, in certa misura comprensibile ai tempi per la scarsa disponibilità di testi canonici tradotti in lingue occidentali moderne e di studi critici su di essi, ma oggigiorno del tutto insostenibile.
Se volessimo citare un testo canonico atto a smentire inequivocabilmente e in modo particolarmente chiaro questa interpretazione, potremmo far riferimento, innanzitutto, allo Yamaka-sutta (SN 22.85), dove si dice che nel bhikkhu Yamaka sorse il dannoso punto di vista errato secondo cui un bhikkhu che ha distrutto gli āsava (khīṇāsava), ovvero gli influssi nocivi che contaminano la mente, quando il suo corpo perisce, viene annichilito (ucchijjati) e svanisce (vinassati), e non è più dopo la morte (na hoti paraṃ maraṇa) (PTS 3.109). Nel tentativo di far abbandonare a Yamaka il suo pernicioso punto di vista, il sapiente Sāriputta gli rivolge una serie di domande, chiedendogli anzitutto, come accade anche in altri sutta (ad es., SN 22.59), se ciascuno degli aggregati costitutivi della persona (khandha) sia permanente o impermamente. Yamaka risponde correttamente: ogni aggregato è impermanente. Attraverso successive domande, Yamaka riesce infine ad abbandonare la sua visione dannosa, e addirittura, avendo ascoltato questo insegnamento di Dhamma da parte di Sāriputta, la sua mente (citta) fu liberata (vimutta) dagli āsava in virtù del non-attaccamento (anupādāya) (PTS 3.114).
Ora, poiché la sua comprensione iniziale dell’insegnamento del Buddha viene esplicitamente respinta come travisamento, è chiaro come il destino dopo la morte da parte di un bhikkhu che abbia distrutto gli āsava, ovvero di un arahant, non sia intendibile in termini puri e semplici di annichilimento. Ciò che segue alla morte di un arahant non è rappresentabile né come esistenza né come inesistenza, tali categorie risultando inadeguate già in riferimento al mondo, come si apprende dal famoso Kaccānagotta-sutta (SN 12.15), tanto più rispetto alla liberazione finale, con la quale si oltrepassa definitivamente la dimensione mondana nel suo complesso.
Giova ricordare cosa dice il Buddha a Kaccānagotta nel sutta che porta il suo nome: il mondo per la maggior parte dipende dalla dualità di esistenza (atthitā) e inesistenza (natthitā). Ma chi vede con retta comprensione (sammappaññā) e secondo realtà (yathābhūtaṃ) l’origine del mondo (lokasamudaya), supera la nozione di inesistenza in riguardo al mondo medesimo; d’altra parte, chi vede con retta comprensione e secondo realtà la cessazione del mondo (lokanirodha), supera la nozione di esistenza in riferimento al mondo (PTS 2.16). Anche nel Dutiyakassapa-sutta (SN 2.2), analogamente, il bhikkhu è invitato a conoscere del mondo il suo sorgere e passare (udayabbaya) (PTS 1.45).
Alla luce di ciò, la retta visione (sammādiṭṭhi) riconosce che la posizione tutto esiste (sabbamatthi), questo è un estremo (ayameko anto), e che la posizione nulla esiste (sabbaṃ natthi), questo è un secondo estremo (ayaṃ dutiyo anto). Non abbracciando entrambi questi estremi, il Tathāgata insegna il Dhamma di mezzo, vale a dire il processo, consistente nel paṭiccasamuppāda, che conduce all’origine e, all’inverso, alla cessazione di questa intera massa di sofferenza (evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa) (PTS 2.16).
Del nibbāna si enfatizza l’alterità rispetto a tutto quanto è condizionato, puranche gli stati più profondi e pacifici conseguibili, quelli dei jhāna, pur sempre di natura composta (saṅkhata), e la sua conseguente ineffabilità: il destino finale di un liberato è dunque indicibile, ma da ciò non si è autorizzati a trarre la conclusione che si tratti di annichilimento. Non per il fatto di essere indescrivibile una cosa è inesistente. È significativo che nel Paṭhamanibbānapaṭisaṃyutta-sutta (Ud 8.1, PTS 79), come pure nell’Ajāta-sutta (Iti 43, PTS 36), il Buddha cominci col verbo atthi, ovvero “c’è”, “esiste”, dal che si è legittimati a dedurre, anche in virtù dell’uso del termine tadāyatana (traducibile come “quella dimensione”, “quella sfera”, “quel dominio” o “quella base”), che il nibbāna sia un esistente, non niente: qualcosa, sia pure di difficile – o impossibile? – definizione, che ha un’esistenza positiva, non meramente negativa, cioè come semplice assenza di tutto quel che caratterizza la realtà condizionata.
Sull’indescrivibilità del liberato dopo la morte il Dutiyadabba-sutta (Ud 8.10, PTS 93) dice che è ignoto, nel senso di essere indescrivibile, il destino (paññāpetuṃ gati natthi) di quelli rettamente liberati (sammāvimutta), che hanno trasceso il flutto dei legami sensuali e conseguito l’incrollabile felicità o beatitudine (acalaṃ sukhan). Infatti, in totale assenza degli aggregati, nulla può più essere detto della persona definitivamente liberatasene dopo la morte, quand’essi non più si manifesteranno. Che nell’estinzione finale manchino gli aggregati è detto dal Buddha stesso in versi nel Paṭhamadabba-sutta (Ud 8.9, PTS 92) dopo aver assistito al prodigioso spegnimento ultimo di Dabba. A questo punto, il Buddha pronuncia il seguente detto ispirato (udāna): distrutto il corpo (abhedi kāyo), cessata la percezione (nirodhi saññā), raffreddatesi tutte le sensazioni (vedanā sītibhaviṃsu sabbā), placati i coefficienti (vūpasamiṃsu saṅkhārā), terminata la coscienza (viññāṇaṃ atthamāgama).
Due osservazioni s’impongono: anzitutto, il termine che indica il corpo non è rūpa, ma kāya; in secondo luogo, l’ordine di presentazione dei khandha, peraltro non menzionati esplicitamente come tali, non è quello usuale, poiché ivi si antepone saññā a vedanā. Ma il senso complessivo del passo rimane immutato: con quello che nella letteratura esegetica è chiamato non a caso khandha-parinibbāna (Gethin 1998: 76), i costituenti fisici e mentali dell’essere umano non si manifesteranno ulteriormente e, dunque, non ci sarà alcuna nuova persona. Lo stato conseguibile in vita che più vi si avvicina è quello noto come saññāvedayitanirodha (“cessazione di nozioni ed esperienza”), che può essere raggiunto per avere già nella presente esistenza un assaggio della misteriosa liberazione finale che occorre dopo la morte di un arahant: misteriosa per due motivi interrelati, ovvero sia perché nulla può esserne detto, essendo inconcepibile attraverso categorie mondane, sia perché, di conseguenza, lo stato del nibbāna dopo la morte dell’arahant non è discusso da nessuna parte nel Canone pāli.
Le questioni sul destino del liberato dopo la morte, formulate secondo il tetralemma[5], sono tutte deliberatamente lasciate senza risposta (avyākata) dal Buddha. Nella Upasīvamāṇavapucchā del Sn, a questo riguardo si dice che, come una fiamma spenta dalla forza del vento “scompare e non è più suscettibile di denominazione” (atthaṃ paleti na upeti saṅkhaṃ) (Talamo 2019: 337), così pure è per il muni liberato da nome-corpo (nāmakāyā) (PTS 205): egli è incommensurabile, non è più definibile, è inenarrabile, come si ribadisce poco dopo: “a colui che si è dissolto non è applicabile alcun predicato, a lui non è più nulla per cui si possa parlarne: annullate tutte le qualità, anche tutte le definizioni vengono annullate” (Talamo 2019: 338).
Una cosa del tutto analoga viene sostenuta nel Khemā-sutta (SN 44.1), dove la monacada cui prende il nome il discorso afferma che, come non è possibile quantificare l’acqua dell’oceano, così il Tathāgata, libero dagli aggregati che ne rendono possibile la descrizione, come il grande oceano è profondo (gambhīra), incommensurabile (appameyya) e difficile da scandagliare (duppariyogāha), e a lui non si addice alcuna delle possibilità logiche del tetralemma, ovvero: il Tathāgata dopo la morte esiste, non esiste, esiste e non esiste, né esiste né non-esiste (PTS 4.375). Nel prosieguo del discorso, tutto ciò viene ribadito dal Buddha medesimo negli stessi termini.
Un ulteriore testo significativo rispetto all’indescrivibilità del liberato è l’Aggivacchagotta-sutta (MN 72), dove il Buddha nega ciascuno dei punti del tetralemma in riferimento al destino di un bhikkhu con mente liberata (vimuttacitta): non se ne può dire né che sorga di nuovo né che non sorga di nuovo né che sorga e insieme non sorga di nuovo né, infine, che né sorga né non sorga di nuovo (PTS 1.485). Di ognuna di queste possibilità il Buddha dice na upeti, non si conviene: sarebbe come chiedersi dove sia andato un fuoco estintosi per mancanza di combustibile. Allo stesso modo, qualsiasi aggregato attraverso cui sarebbe possibile descrivere il Tathāgata è stato abbandonato (pahīna), tagliato alla radice (ucchinnamūla), sradicato come una palma (tālāvatthukata), del tutto annichilito (anabhāvaṅkata), in modo tale da non poter mai più sorgere (anuppādadhamma) in futuro (āyatiṃ) (PTS 1.487).
Liberato dall’esaustione della forma (rūpasaṅkhayavimutta), come dei rimanenti aggregati, il Tathāgata è profondo, incommensurabile, difficile da scandagliare, proprio come il grande oceano, e rispetto al suo ri-sorgere (upapajjati) non si applica alcun punto del tetralemma. Ma in effetti già nella vita presente il Tathāgata non è rintracciabile, è introvabile (ananuvijja), come dice il Buddha stesso nell’Alagaddūpama-sutta (MN 22, PTS 1.139). Il commentario interpreta questo passo in due modi: uno fa riferimento al non-sé, sicché il Tathāgata, ma più in generale l’arahant, è introvabile qui e ora nel senso di mancare di un essere permanente; l’altro invece si riferisce al nibbāna, ovvero, poiché la sua mente ha questo come oggetto, essa non è conoscibile dai mondani.
Conclusione
Nel presente studio, muovendo da un passo situato all’inizio del Sn, si è dimostrato, con riferimento a come il commentario lo interpreta, che la lettura nichilista, cui di primo acchito si presterebbe, risulta invero infondata. La prima impressione non è necessariamente quella corretta: l’aggettivo vitatha, infatti, viene interpretato come carattere “falso” o “irreale” del mondo nel senso relativo, anziché assoluto, di mostrarsi come dotato di caratteristiche contrarie a quelle autentiche, che solo una mente purificata è in grado di vedere e conoscere profondamente. Ciò prova la grande rilevanza che assume la letteratura commentariale – non sempre tenuta nel giusto conto, anche a motivo del fatto che larga parte attende di essere tradotta in lingue occidentali moderne e di essere resa così accessibile ad un pubblico più ampio della ristretta cerchia dei pālisti – nell’interpretazione dei testi canonici rispetto a loro singoli termini o passaggi che altrimenti non si saprebbe bene come spiegare. Il riferimento incrociato con altri testi canonici in cui ricorrono concetti o espressioni identiche o simili può certo essere un ausilio esegetico, ma non sempre questo modo di procedere è sufficiente a dissipare ogni dubbio interpretativo.
Si è quindi passati all’analisi di quelle distorsioni cognitive, i vipallāsa, cui l’essere umano ordinario è soggetto, filtrando la propria esperienza attraverso categorie queste sì davvero irreali, nel senso della mancata corrispondenza con quanto una spassionata visione della realtà rivela della stessa. A seguire, si è discusso del tipico concetto buddhista di non-sé, ovvero di vacuità, mostrando come anch’esso, se rettamente inteso, sia incapace di fornire un solido fondamento ad una interpretazione di tipo nichilista. La vacuità del mondo difatti è spiegata in modo da escludere non la sua realtà, ma la sua esistenza come permanente, soddisfacente e sostanziale. Solitamente, quello di vacuità è un concetto associato al Mahāyāna e alla sua letteratura fondativa, i Prajñāpāramitāsūtra, eppure abbiamo avuto occasione di ricordare come anche il Canone in lingua pāli non solo lo conosca, ma ne abbia finanche sviluppato una nutrita tassonomia, discussa analiticamente in ogni suo elemento, nel Paṭisambhidāmagga.
Finalmente, si è affrontato un altro possibile fraintendimento nichilista, storicamente effettuatosi: quello per cui, se non il mondo, se non il condizionato, quantomeno il nibbāna supporti, già per il suo stesso nome, una visione nichilista del buddhismo, in particolare del suo fine soteriologico. Ma anche questa sarebbe ed è, in effetti, una lettura tendenziosa, che omette i passaggi canonici (per tacere di quelli desumibili dai commentari) in cui del nibbāna viene presentata una serie di qualificazioni che ben ne rappresenta l’esistenza come realtà positiva e non come semplice mancanza, come mera nullità, tant’è vero da essere qualificato, nel Dvayatānupassanā-sutta del Sn, come di natura non decettiva (amosadhamma) (PTS 147). È vero che nello stesso sutta si afferma che i nobili (ariya) vedano positivamente la fine della personalità (sakkāyassuparodhanaṃ), ovvero, come glossa il commentario, la cessazione dei cinque aggregati (pañcakkhandhanirodha), cioè il nibbāna (Bodhi 2017: 1008), ma ciò vale più a sottolineare la natura incondizionata e ineffabile di questo che, appunto, la sua nullità.
L’augurio è che il presente articolo contribuisca alla diffusione di una prospettiva sul buddhismo più aderente ai testi canonici e commentariali considerati, riducendo, se non proprio azzerando, la portata esplicativa della lettura nichilista, che storicamente ha avuto le sue ragioni per formarsi e affermarsi, resistendo finanche ai giorni nostri presso parte del pubblico non specialista, ma che con l’acuirsi dell’acume storico-critico degli studiosi risulta oggi non più sostenibile.
BIBLIOGRAFIA
Letteratura primaria
Bodhi, B. (a cura di) (2017), The Suttanipāta: An Ancient Collection of the Buddha’s Discourses Together With Its Commentaries, Somerville, Wisdom Publications.
Comba, A. S. (a cura di) (2010), Visuddhimagga, Il Sentiero della Purificazione, voll. I-III, Edizioni Lulu.
Conze, E. (a cura di) (1976), I Libri Buddhisti della Sapienza, Roma, Astrolabio-Ubaldini.
Ñāṇamoli, B. (a cura di) (2009), The Path of Discrimination (Paṭisambhidāmagga), Oxford, Pali Text Society.
Talamo, V. (a cura di) (1998), Saṃyutta Nikāya, Roma, Astrolabio-Ubaldini.
ID. (a cura di) (2019), Canone Buddhistico. Testi Brevi: Dhammapada, Itivuttaka, Suttanipāta, Torino, Bollati Boringhieri.
Letteratura secondaria
Anālayo, B. (2018), Satipaṭṭhāna. Il Cammino Diretto, Poggio Nativo, Santacittarama Edizioni.
Dhammajoti, K. L. (2009), Sarvāstivāda Abhidharma, Centre of Buddhist Studies, University of Hong Kong.
Gethin, R. (1998), The Foundations of Buddhism, Oxford, Oxford University Press.
Gokhale, P. P. (2020), The Yogasūtra of Patañjali: A New Introduction to the Buddhist Roots of the Yoga System, New York, Routledge.
Gombrich, R. (2012), Il Pensiero del Buddha, Milano, Adelphi.
King, R. (1995), Early Advaita Vedānta and Buddhism. The Mahāyāna Context of the Gauḍapādīya-kārikā, New York, State University of New York.
Kosaka, A. (2021), The Mādhyamikas on False Conception (viparyāsa) and Emptiness (śūnyatā): A Study of Chapter Twenty-Three (Viparyāsaparīkṣā) of the Mūlamadhyamakakārikā and Prasannapadā, University of Tsukuba.
Nyanaponika, T. (2009), The Worn-out Skin Reflections on the Uraga Sutta, Kandy, Buddhist Publication Society.
Pelissero, A. (2014), Filosofie Classiche dell’India, Brescia, Morcelliana.
Ruegg, D. S. (1981), The Literature of the Madhyamaka School of Philosophy in India, Wiesbaden, Otto Harrassowitz.
von Hinüber, O. (1996), A Handbook of Pāli Literature, Berlin, Walter de Gruyter.
Williams, P. (1990), Il Buddhismo Mahāyāna. La Sapienza e la Compassione, Roma, Astrolabio-Ubaldini.
ID. (2002), Il Buddhismo dell’India. Un’introduzione completa alla Tradizione Indiana, Roma, Astrolabio-Ubaldini.
[1] È possibile, ma la questione certo andrebbe affrontata in una ricerca specifica, che questo lavoro di classificazione e discussione analitica delle diverse specie di vuoto abbia avuto luogo in relazione coi coevi sviluppi dell’emergente letteratura fondativa del Mahāyāna, ovvero i Prajñāpāramitāsūtra, i più antichi dei quali sarebbero antecedenti al presunto periodo di composizione del Paṭisambhidāmagga. È, dunque, cronologicamente compatibile che la Suññakathā possa essersi definita, gradualmente o meno, tenendo conto dell’incoante filosofia del Mahāyāna, peraltro allora non ancora consapevole di sé come tale.
[2] Non molto tempo dopo, Gauḍapāda (VI d.C.?) nelle sue Gauḍapādīyakārikā (IV, 47) si servirà della medesima immagine (Pelissero 2014: 150), peraltro con una finalità affatto diversa: “The author of GK IV wishes to establish the non-dual substratum of the world appearance. To do this the author emphasizes the role of the firebrand as the non-dual reality behind the fluctuating images” (King 1995: 178). Nel contesto buddhista, lo scopo di questa metafora è invece di mostrare come il cerchio prodotto dal rapido roteare di una torcia nel buio sia solo illusoriamente unitario e persistente: invero, il circolo igneo si compone di una serie di flash luminosi discreti che vengono unificati percettivamente in un’immagine singolare. Ma se si osservasse più da presso e come al rallentatore il cerchio di fuoco si scoprirebbe la sua composizione data da numerosi punti ignei, reciprocamente separati pur se contigui, solo a causa di una percezione grossolana veduti come un unico e irriducibile ente.
[3] Queste immagini ricordano quelle adoprate nel celebre Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtra, dove alla fine si è invitati a contemplare il condizionato “come stelle, un difetto della vista, come lampada, un finto spettacolo, gocce di rugiada, o una bolla, un sogno, un lampo balenante, o nuvola” (Conze 1976: 60-61). Williams (2002: 85), non a caso, ha richiamato l’attenzione sulla prossimità tra il passo di Buddhaghosa e i Prajñāpāramitāsūtra (“Discorsi della perfezione della gnosi”).
[4] MN 35 (PTS 1.227), SN 22.90 (3.131-132), SN 44.10 (PTS 4.399), AN 3.136 (PTS 1.285), Dhp 279 (PTS 39).
[5] Il tetralemma (sanscrito: catuṣkoṭi) è uno schema logico-dialettico, attestato già nel Canone pāli (ad es., SN 56.8), che articola le possibilità predicative in riferimento ad un dato argomento attraverso quattro modalità: P, ¬P, P ∧ ¬P, ¬P ∧ ¬¬P.
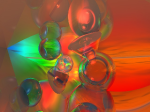
Pingback: Un po’ di personaggi esoterici con Perplexity – Viaggiatore del Web